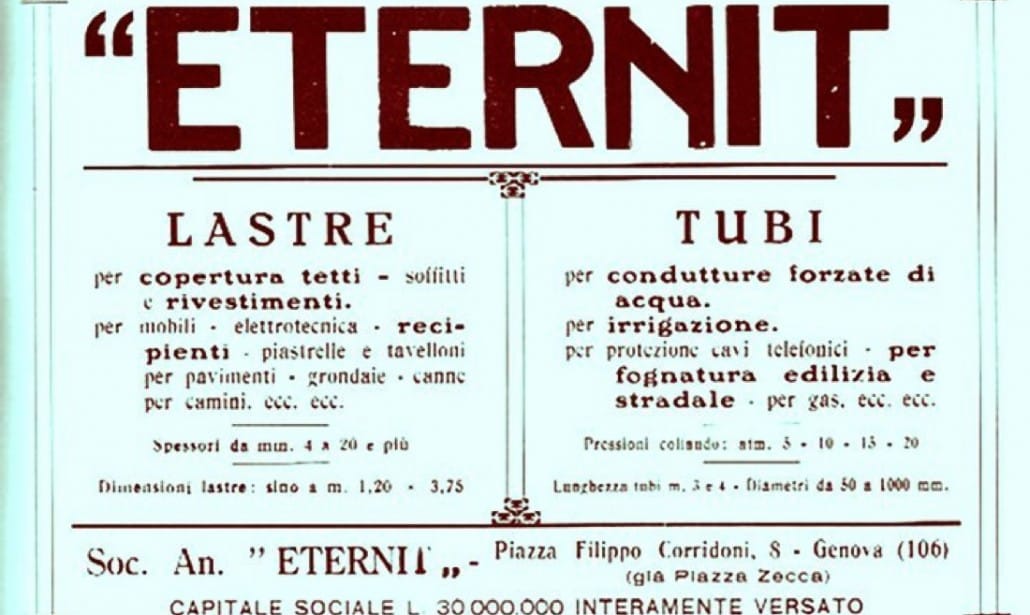Eliminata l’ostatività alla sospensione dell’esecutività della pena per i minorenni. Un passo avanti per il principio del recupero del condannato
in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5 – ISSN 2499-846X

Corte Cost. 28 aprile 2017 (ud. 22 febbraio 2017), n. 90
Pres. Grossi, Rel. Lattanzi
Con la sentenza citata è stato raggiunto l’obiettivo di consentire a coloro che hanno commesso il reato da minorenni di evitare l’ingresso in carcere per qualunque reato, senza eccezioni automatiche, così da garantire la prosecuzione di un percorso educativo o lavorativo.
La scintilla è venuta dal cappellano dell’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria di Milano, Don Gino Rigoldi, che assisteva, nella sua esperienza di prete ed educatore, all’ingresso in carcere di giovani, non più minorenni, che si erano già fatti una vita di genitori e nel lavoro, con le inevitabili tristi conseguenze.
La decisione si inserisce nell’alveo di un percorso intrapreso dalla stessa Corte Costituzionale, che ha arricchito la normativa di cui al DPR 448/88, individualizzandola ancora di più rispetto alla normativa generale del Codice Penale e di Procedura Penale, con il fine di proteggere la gioventù e favorire gli istituti necessari a tale scopo, come imposto dall’art 31 della Carta Costituzionale.
Tale percorso è stato caratterizzato da una serie di sentenze aventi ad oggetto la constatazione che il processo penale a carico di imputati minorenni dovesse caratterizzarsi per la specifica funzione di recupero del minore, assunta a peculiare interesse-dovere dello Stato, anche a scapito della pretesa punitiva, che deve rimanere sempre subordinata al recupero del minore (Sent. 49/1973) ed in questo senso si rendesse necessario differenziare il trattamento dei minorenni rispetto agli adulti, eliminando automatismi applicativi nell’esecuzione della pena (Sent. 125/1992 e 109/1997).
In particolare, la Corte Costituzionale aveva già stabilito che non vi dovessero essere preclusioni per l’applicazione delle sanzioni sostitutive per i minorenni (sent 190/1998); i benefici della Legge Penitenziaria si potessero dare sulla pena derivante da conversione di pena sostitutiva (sent. 190/1997); i permessi premio ex art. 30 ter Ord. Pen potessero essere concessi senza limiti temporali (sent. 403/1997); il divieto di concessione dei benefici della Legge Penitenziaria non potesse valere per i tre anni dalla revoca di precedenti come in generale imposto ex art. 58 quater Ord. Pen (436/1999).
Il decreto 448/88 già di per sé contiene istituti che favoriscono il recupero sociale del minorenne, perché derogano all’esecuzione concreta della pena, non interrompendo processi educativi in atto. Ci si riferisce alla misura cautelare del collocamento in comunità (art. 22), della sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 28, applicabile per qualunque tipo di reato, a differenza di quella di recente applicazione per gli adulti), la mediazione tra indagato e parte lesa (art. 9), l’irrilevanza del fatto.
In questa ottica, la Corte Costituzionale ha ritenuto di eliminare l’automatismo più evidente che impediva la prosecuzione di un percorso di recupero in atto, o che avrebbe minato le fondamenta di uno in fieri, ovvero la non sospensione dell’esecuzione della pena in presenza di determinati reati ritenuti più gravi dal Legislatore, ovvero quelli di cui all’art. 656 co 9 lett. a) c.p.p.
Se il Legislatore ritiene di tutelare il minorenne nell’ambito del procedimento penale in corso con istituti come – ad esempio – la sospensione del processo per messa alla prova o il collocamento comunitario, a maggior ragione questa tutela è stata individuata nella fase finale del procedimento, allorquando la pena deve essere eseguita. La tutela riguarda evidentemente, sia il minorenne che ha in corso un progetto di recupero, sia il minorenne che non ne ha ancora.
Questo aspetto, che l’Avvocatura dello Stato in sede di discussione il 22/2/17 ha evidenziato come elemento di genericità, in realtà è stato ritenuto compatibile con la tutela complessiva del minorenne. Se da un lato l’esistenza di un percorso di recupero già esistente sarebbe motivo più valido per sospendere l’esecuzione della pena, dall’altro la possibilità di verificarlo sempre preventivamente, prima di sospendere l’esecuzione della pena, sarebbe assai arduo.
Tale percorso, infatti, potrebbe essere certificato evidentemente dai Servizi Sociali, deputati nel processo minorile al controllo del minorenne; ma sarebbe difficile, per il Pubblico Ministero che deve eseguire la pena, verificarne l’esistenza prima di sospenderla, nonchè per l’interessato o il difensore intervenire in tempo provandolo, prima appunto dell’esecuzione della pena.
Esattamente come avviene in caso di istanza di affidamento terapeutico ex art 94 DPR 309/90 per pene superiori a 3 anni ma inferiori a 4 o 6, in cui l’istanza di affidamento deve intervenire prima che l’ordine di esecuzione venga eseguito e quindi il difensore o l’interessato deve tenere sotto controllo l’esecutività della pena, facendo “picchetto” presso la cancelleria della Procura ufficio esecuzione, nel caso dell’esecuzione penale per i minorenni tale solerzia non sarebbe così facile in presenza spesso di minorenni difesi da difensori di ufficio, che magari non hanno mai visto il cliente, o di minorenni che comunque, per negligenza connaturata alla loro età ed immaturità, non tengono contatti con gli stessi, anche se di fiducia.
A differenza degli adulti per i quali una negligenza potrebbe essere tollerata, ciò non può avvenire per un minorenne, per la loro stessa tutela. La pronuncia di cui in discussione riguarda il diritto minorile; tuttavia, si ritiene siano presenti aspetti che possano essere estesi anche alla normativa ordinaria, riguardante gli adulti. Ci si riferisce al fatto che emerge come centrale l’art. 27 della Costituzione, ovvero la necessità che la pena sia concretamente finalizzata al recupero del condannato.
È vero che nella sentenza de quo l’art. 27 è connesso all’art. 31; però, è altresì vero che un aspetto, che possa essere connesso a tale art. 27 nell’ambito della normativa ordinaria, è la tutela del lavoro. Alla pari del minorenne, per il quale si rende oramai necessario garantire il nascere o la continuazione di un progetto educativo al fine del recupero sociale, allo stesso modo, al medesimo fine si dovrebbe rendere necessario garantire l’inizio o la prosecuzione di un’attività lavorativa in corso, che è tutelata dall’art. 1 della Costituzione.
Comunque, la medesima questione accolta dalla Corte Costituzionale potrebbe essere estesa alla figura dei c.d. “giovani adulti”, ovvero coloro che sono infraventicinquenni e che quindi hanno commesso i reati da maggiorenni.
Una figura questa non prevista normativamente, se non per il solo fatto che il minorenne detenuto in un IPM per reati da minorenne può rimanere nel medesimo istituto fino all’età di 25 anni, ma che nella sostanza è riconosciuta all’interno degli istituti penitenziari, ove sono previste sezioni o programmi di trattamento speciali, in quanto connessa al concetto di gioventù, così vario e liquido, soprattutto in questo periodo storico.
Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Ranieli, Eliminata l’ostatività alla sospensione dell’esecutività della pena per i minorenni. Un passo avanti per il principio del recupero del condannato, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 5