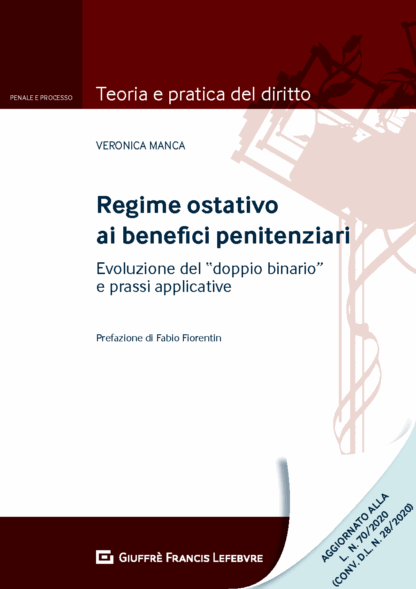Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3 – ISSN 2499-846X

Un grido di disperazione e di rabbia quello che arriva dalle carceri italiane. Si veste di violenza che a violenza risponde e incarna un’iconografia rasserenante. Eccoli, i delinquenti nelle patrie galere. Bruciano, picchiano, distruggono. Criminali da contenere con strumenti più capaci, con mezzi più feroci, con metodi più forti. Così funziona il karma nazionalpopolare. E ci troviamo placidi a guardare il dito (i focolai delle rivolte) e non la luna (l’orrore di un sistema penitenziario fatiscente che riduce gli uomini a bestie in gabbia).
Ma di che si lamentano? Stessero buoni, hanno consentito loro di telefonare a casa qualche volta in più. E’ emergenza per tutti. Tutti noi ci sentiamo privati della nostra quotidianità e costretti nelle maglie di un vivere imposto da un sentire condiviso di auto tutela e di protezione solidale degli altri. E allora loro, i detenuti, che pure sono ristretti perché colpevoli, marchiati a fuoco di indelebile infamità, proprio loro di che si lagnano?
Hanno tre metri quadri a testa in una cella compresi gli elementi di arredo. Forse anche inclusi i letti dove dormono, sono state scomodate le Sezioni Unite della Cassazione per deciderlo. Poco meno della metà dello spazio riservato ai verri adulti dalle direttive comunitarie. Ma di che si dolgono?
Mentre tutto si ferma, in un silenzio surreale, e si comprano scorte di mascherine, amuchina, candeggina, alcool, ammoniaca e ogni genere di protezione e di sostanza disinfettante e igienizzante, si sta attenti a non incontrarsi e a non avvicinarsi gli uni agli altri, si acquistano generi alimentari in quantità per non rischiare di stare in fila, di respirare la stessa aria, c’è un mondo altro, quello recluso, che si scontra con la propria inerme impotenza. Il virus arriverà, se deve. L’aria è poca nelle celle. Alcune hanno lamiere di ferro; tutte, o quasi, griglie a tutta altezza. I muri sudano muffa e umidità e i prodotti per disinfettare li avrà chi può comprarli. L’acqua c’è, quasi sempre; quella calda spesso. I lavandini servono a tutte le esigenze di pulizia, quelle del corpo, dei panni, dei piatti e delle stoviglie di tutti i coinquilini. Le docce nelle celle sono un bene di lusso, da condividere comunque con quanti abitano lo stesso spazio asfittico. Le camere di pernottamento – così bisogna chiamarle per un bon ton del linguaggio che fa dei ciechi non vedenti, dei sordi non udenti, di chi ha un handicap diversamente abile, di chi è detenuto diversamente vivo – ospitano anche sei brande, una sull’altra, in letti a castello, così i tre metri quadri sono rispettati, qualunque cosa dicano le Sezioni Unite.
Intanto ogni mezzo di informazione propaga le notizie del contagio, i numeri di una pandemia che sembra inarrestabile, la conta delle vittime. In ogni momento della giornata il tam tam mediatico ti raggiunge con il suo rumore e si insinua nella carne con l’imperativo della paura. Nel non luogo degli istituti di pena lo stesso imperativo si trasforma in sgomento, in terrore, in panico. Il virus arriverà, se deve. Non c’è modo per proteggersi per quegli uomini, colpevoli o non, privati della libertà personale ed affidati allo Stato cui è demandata la loro custodia, la loro salute, la loro speranza di riabilitazione, la loro dignità. E’ fin troppo evidente che un solo episodio di contagio per quella umanità così reclusa si tradurrebbe in una epidemia incontrollabile ma la protezione ha un costo elevatissimo ed a pagarlo sono i detenuti. I colloqui con i familiari vengono sospesi, così i permessi premio, boccate di ossigeno ottenute magari dopo anni e anni di totale restrizione. Ai volontari cui è relegata grandissima parte dell’organizzazione e della gestione delle attività di formazione, istruzione e ricreazione, è fatto divieto di entrare. Il tempo si dilata all’infinito. E’ rotto, fermo, inutile. Gli attimi, i minuti, le ore, perfino il giorno e la notte si confondono e scivolano, liquidi e informi.
La disperazione prende il sopravvento e si traduce nello scempio di una rivolta esplosa su un materiale pirotecnico cui basta poco più di una scintilla ed a contenerla trova un personale di polizia penitenziaria mai numericamente adeguato e sempre avvezzo a condividere una situazione patologica immanente.
Ferma la condanna a ogni violenza, di uomini o di Stato, è tempo di rimediare. Ridurre i numeri del sovraffollamento con misure immediate ed adeguate. Amnistia per i reati meno gravi; indulto per le pene inferiori ai due anni; arresti o detenzione domiciliare laddove sussistano esigenze di sicurezza da tutelare. Il carcere sia davvero extrema ratio, quando ogni altra misura risulti inadeguata. Si rendano disponibili più braccialetti elettronici ché sono già in tanti i ristretti che li aspettano con in mano un provvedimento inutile di concessione dell’autorità giudiziaria. Si adotti ogni strumento idoneo a ripristinale la legalità nelle carceri in un’ottica di deflazione che è aspirazione di giustizia e di umanità. Si insegua non la sterile punizione ma la sicurezza delle persone e la loro dignità che è restare parte di una comunità e poter scegliere di tenere l’altro a un metro di distanza.
Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Brucale, Coronavirus. Rivolte in carcere: dalla violenza, la violenza, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 3