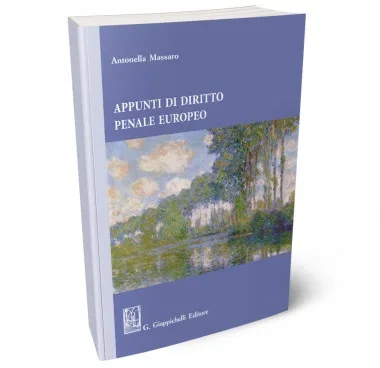La capacità giuridica del reo imputabile rispetto al singolo fatto di reato: l’apporto delle scienze cognitive al processo decisionale giuridico. Una implementazione non ancora compiuta?
in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3 – ISSN 2499-846X

Il presente contributo è stato animato dall’unico e solo intento di presentare timidi spunti di riflessione in un ambito, quale quello dell’accertamento della imputabilità del reo, costituente ancora oggi uno dei temi più evanescenti e dibattuti del diritto penale e della neuroscienza.
Attraverso l’analisi e il richiamo delle principali pronunce giurisprudenziali, si sono voluti indagare i limiti e l’ampiezza dei poteri d’indagine del giudice di merito, il quale – nell’ambito delle proprie prerogative – è chiamato sovente ad assumere e maneggiare con fatica quella prova (neuro) scientifica – ponte tra il mondo empirico e quello normativo – ai fini di una decisione giudiziale.
Un compito che pur non potendo prescindere da un approccio multidisciplinare che trovi nella psicologia-psichiatrica-forense i migliori strumenti d’indagine, non deve tuttavia finire per divenire un’accettazione fideistica alle conclusioni aventi natura squisitamente tecnico-scientifica.
Il momento cognitivo affidato al perito non deve sostituire, infatti, il momento valutativo rimesso esclusivamente al giudice, chiamato a fornire una risposta che tenga conto del dialogare di due diversi mondi, le cui categorie – nel caso di specie – vengono ad intrecciarsi indissolubilmente. Ogni automatismo o visione totalizzante della malattia renderebbe evidente il bias logico, e ancor prima metodologico, sotteso ad una pronuncia assolutoria per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto: il quadro psichiatrico dell’imputato, seppur di notevole problematicità, non può e non deve per ciò solo confondersi con il giudizio sulla capacità di intendere e volere dello stesso, specie se non rapportato al fatto specifico.
Il giudice, chiamato a pronunciarsi nell’ambito quivi indagato, dovrebbe resistere al mero recepimento delle conclusioni tecno-scientifiche, addivenendo ad una risposta giuridica che tenga conto del complesso delle risultanze probatorie, in conformità con le logiche dell’imputazione. Di talché, nel rispetto dei principi sottesi alla materia in gioco, l’accertamento del caso non può prescindere dall’esame della condotta e della personalità dell’imputato, nonché dalle modalità dei fatti commessi, specie attraverso una ricostruzione della criminodinamica che consenta di addivenire alla ricostruzione del nesso causale.
Un giudizio su due livelli che, partendo dalla presenza o dalla entità dell’affezione, arrivi a concludere se, e in che misura, la stessa sia stata elemento condizionante della condotta criminale; un accertamento che deve passare necessariamente per il metodo psicopatologico normativo, a mente del quale occorre valutare l’incidenza della malattia di mente ovvero della anomalia psichica, valutata prima, sul processo psichico dell’uomo, senza che si cada nella fallacia logica di assimilare la prima condizione alla seconda.
In tale passaggio si cela sovente l’error iudicis nel quale possono incorrere gli operatori del diritto, chiamati ad esprimere un giudizio che, delegando in toto la propria funzione alla scienza, parrebbe finire per assumere convinzioni provenienti da altri campi e ruoli del sapere.
Come citare il contributo in una bibliografia:
A. Iapicca, La capacità giuridica del reo imputabile rispetto al singolo fatto di reato: l’apporto delle scienze cognitive al processo decisionale giuridico. Una implementazione non ancora compiuta?, in Giurisprudenza Penale Web, 2025, 3