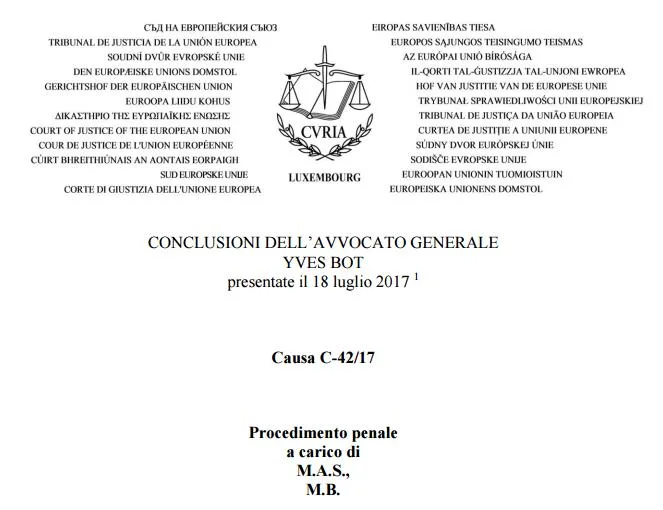Caso Turetta (omicidio Giulia Cecchettin): le motivazioni della sentenza della Corte di Assise di Venezia

Corte di Assise di Venezia, 8 aprile 2025 (ud. 3 dicembre 2024), n. 2/2024
Presidente dott. Manduzio, Estensore dott.ssa Zancan
Segnaliamo ai lettori, in relazione al processo per il sequestro e l’omicidio di Giulia Cecchettin, le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Assise di Venezia, in data 3 dicembre 2024, ha condannato l’imputato Filippo Turetta alla pena dell’ergastolo.
Si riporta di seguito un estratto di alcuni dei passaggi in diritto della sentenza, disponibile più in basso per intero (ad eccezione di dettagli e chat che sono state oscurate).
***
- Aggravante della premeditazione (pagina 111 della sentenza)
Quanto alla aggravante della premeditazione, la Corte di Assise prende le mosse ricordando come, «dopo l’ennesimo litigio sorto perché la persona offesa aveva deciso di non volergli più dare la buonanotte, preso atto della fallacia dì ogni suo tentativo diretto e indiretto di tenerla sotto il suo controllo e cogliendo l’ulteriore segnale inequivocabile del fatto che Giulia si stava inesorabilmente allontanando da lui, quando ancora era in corso tale discussione, Turetta abbia creato nella app Note del proprio cellulare una lista di oggetti e di attività univocamente strumentali all’omicidio della ragazza».
Elemento, quest’ultimo, «che consente di cristallizzare il momento in cui matura in lui il proposito omicida: proposito certamente favorito dal sentimento di rabbia e acredine che montava nell’imputato ogni qualvolta venisse frustrato il suo senso di possesso nei confronti della ragazza (come si ritrova immancabile nelle varie chat), che ha evidentemente finito per piegarsi alla logica perversa del “o con me o con nessuno”». Proposito omicida «di cui vi è prova documentale, dunque, non solo in relazione al momento che ne segna la nascita (con la creazione, appunto, di tale lista), ma anche in relazione alla attuazione pedissequa nei giorni successivi di tutte le attività preparatorie, minuziosamente meditate, che egli ha avuto cura di progressivamente annotare nel telefono, spuntando di volta in volta ogni singola voce quando concretamente adempiuta, sia prima dell’omicidio, sia dopo».
I giudici hanno rigettato l’argomento difensivo – secondo cui tale lista sarebbe stata «rivelatrice della volontà di sequestrare una persona e non di volontà omicida» – osservando che «tale assunto è smentito dalla natura di taluni degli oggetti indicati in detta lista, che non lascia spazio a letture alternative alla finalità per cui detti oggetti sono stati effettivamente e concretamente utilizzati dal Turetta: è il caso, ad esempio, dei sacchi dell’immondizia». Nemmeno – si aggiunge – «si comprende come possa conciliarsi la necessità di un badile con un sequestro di persona, oggetto che tradisce invece la finalità omicida».
In punto di diritto, la Corte osserva come «le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano definito la premeditazione come un’azione ispirata da una particolare intensità del dolo, che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato senza ripensamenti e senza soluzione di continuità». Detta aggravante, dunque, «va esclusa quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato, fermo restando che la premeditazione è invece configurata quando, ricorrendo un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, il delitto già programmato sia eseguito in seguito ad un occasionale incontro con la vittima».
È poi consolidato – aggiunge la Corte – «l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non osta alla configurabilità dell’aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo».
Secondo la Corte, «affermare che l’aggravante in parola non sussiste perché Turetta non avrebbe mai ucciso Giulia Cecchettin se questa avesse deciso di tornare con lui è argomento fallace che ignora e non sì confronta con le acquisizioni probatorie, che dimostrano come Turetta abbia deciso di uccidere Giulia proprio perché aveva capito che era ineluttabile l’allontanamento della ragazza da lui e che non vi era più alcuna possibilità di segno contrario».
In conclusione, secondo i giudici «l’attenta e accurata pianificazione vada ben oltre la preordinazione dei mezzi necessari ad attuare il proposito omicidiario e che il lasso temporale intercorso tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso fosse più che sufficiente a consentire all’imputato di riflettere e ponderare opportunità di recedere da un tanto grave e violento disegno».
- Aggravante dell’aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all’art 612-bis c.p. (pagina 121 della sentenza)
La Corte ha anche escluso l’aggravante di aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui all’art 612-bis c.p. (atti persecutori), contestata dalla Procura – limitatamente al periodo «in prossimità e a seguito del termine della relazione intrattenuta» – perché l’imputato (così si legge nell’imputazione) «attuava un esasperante forma di controllo nei confronti di Giulia Cecchettin, inibendola finanche ad adottare misure volte ad allontanare il Turetta da sé stessa, provocando in lei un grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità».
Fermo restando – si legge nella sentenza – che, «nel procedere all’esame di stati d’animo quali ansia o paura, ognuno ha una sensibilità sua propria di cui si deve tenere conto quando si valuta se sia o meno integrato l’evento richiesto, alla luce di tutti gli atti raccolti nel corso delle indagini, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese dai familiari e dalle persone più vicine alla vittima, non si ravvisano elementi anche solo sintomatici che consentano di ritenere in concreto sussistente in capo a Giulia Cecchettin il contestato “grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità».
In tal senso, la Corte ha valorizzato diversi elementi, tra i quali le dichiarazione del padre della vittima (il quale aveva riferito di non aver percepito alcun disagio in Giulia e che la stessa, con riguardo a due episodi particolari, non si mostrò particolarmente allarmata e reagì in modo spazientito, come a dire “ancora qui che rompe”), le dichiarazioni del fratello della vittima (secondo cui il modo di esprimersi di Giulia gli faceva pensare più al fatto che fosse arrabbiata piuttosto che impaurita), le chat (da cui emerge che Giulia, pur avendo capito che Turetta era ossessionato da lei, fosse del tutto inconsapevole della pericolosità dello stesso e non provasse alcun timore”), il tono e le parole usate dalla persona offesa (ad esempio, “faccio quel cazzo che voglio, se voglio, ok? Non sei nessuno per dirmi cosa fare e cosa non fare”) nonché, da ultimo, il fatto che «fosse stata Giulia stessa a prendere l’iniziativa di proporre al Turetta di accompagnarla a fare acquisti per il giorno della laurea, non solo ignorandone la capacità criminale ma nella totale assenza di qualsivoglia sospetto circa il proposito che questi aveva maturato».
Alla luce di tali evidenze, la Corte ha rigettato l’argomento utilizzato dalla Procura, secondo cui dovrebbe ravvisarsi «l’evento del reato nel fatto che la persona offesa sia stata di fatto costretta ad alterare le proprie abitudini di vita a causa dell’atteggiamento vessatorio e manipolatorio dell’imputato che, facendo leva sui sensi di colpa e sull’assertività della ragazza, l’avrebbe costretta a sostanzialmente continuare a frequentarlo forzandola a fare una serie di cose che lei avrebbe voluto omettere (ad esempio, continuare a dargli la buonanotte)».
L’assunto del pubblico ministero – si legge nella pronuncia – «non convince, per un verso, perché una tale prospettazione sembra far coincidere l’alterazione delle abitudini di vita con il fatto in sé di subire/tollerare le condotte persecutorie, laddove invece l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria. Per altro verso, non si ritiene di poter dilatare nel senso indicato dal pubblico ministero il concetto normativo, pure ampio, di costringere ad alterare le proprie abitudini dì vita, che deve consistere in una modifica qualitativamente apprezzabile dei comportamenti abitualmente tenuti dalla vittima: invero, la prospettiva accusatoria tenta di ravvisare tale concetto non nella costrizione ad alterare bensì nella costrizione a mantenere le abitudini di vita, con un ribaltamento concettuale inammissibile in quanto irrispettoso del principio di tassatività».
In conclusione, «non si ritiene di poter ricondurre al profilo di evento in esame il fatto che la persona offesa abbia continuato a frequentare l’imputato perché si sentiva in colpa, perché questi le faceva pena e perché era una ragazza altruista e generosa. Invero, Giulia Cecchettin era ben consapevole sia della insensatezza delle pretese del Turetta sia del carattere manipolatorio delle affermazioni autolesionistiche di costui e si è visto come ella non si fosse piegata a tali pretese: e proprio per questo è stata uccisa».
- Aggravante della crudeltà (pagina 130 della sentenza)
La Corte ha invece escluso la circostanza aggravante dell’aver agito con crudeltà, «non essendovi elementi da cui poter desumere con certezza, e al dì là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive».
Quanto all’aspetto legato al numero di coltellate, i giudici ricordano come «in tutti i numerosi casi in cui la giurisprudenza si è trovata a doversi occupare di vicende omogenee a quella in esame, caratterizzate dalla insistita ripetizione delle coltellate inferte sulla vittima, sia stato necessario verificare se tale ripetizione di colpi fosse funzionale al delitto ovvero costituisse un gratuito accanimento violento tale da costituire “espressione autonoma di ferocia belluina” e tale da trascendere la mera volontà di arrecare la morte».
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui «non sarebbe ammissibile la fissazione di una “soglia di coltellate” al di sopra della quale ritenere integrata l’aggravante in parola, essendo necessario l’esame delle modalità complessive dell’azione e del correlato elemento psicologico del reato posto in essere» nonché quella secondo cui «sopprimere volontariamente una vita è di per sé atto contrario a qualunque senso di umanità, cui l’ordinamento ricollega la pena del delitto di omicidio».
Anche alla luce di tali principi, la Corte di Assise prosegue osservando che «l’aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene sia stato, per Turetta, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell’ultima fase dell’azione omicidiaria, l’imputato ha aggredito Giulia Cecchettin attingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca».
Non si ritiene che tale dinamica, «come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più”».
Diversamente opinando, «si finirebbe per avallare un inammissibile automatismo nel senso che porterebbe a configurare l’aggravante ogni qualvolta l’omicidio fosse realizzato con arma bianca, implicando essa modalità esecutive inevitabilmente cruente, e ancor di più ad opera di soggetti inesperti».
In conclusione, secondo i giudici della Corte di Assise «con riguardo alle altre caratteristiche dell’azione come in concreto attuata dal Turetta, non vi sono elementi che consentano di individuare indici di incrudelimento, idonei a integrare i presupposti dell’aggravante della crudeltà come definiti dalla giurisprudenza di legittimità: così, ad esempio, l’aver bloccato e silenziato la vittima con il nastro adesivo è circostanza funzionale al delitto e rientra nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria».
- Diniego delle attenuanti generiche (pagina 136 della sentenza)
Secondo la Corte «non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chieste dalla difesa dell’imputato, alla luce della efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita».
Non può nemmeno essere a tal fine valorizzata – si aggiunge – «la confessione del Turetta, dal momento che egli si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti: d’altra parte, tale condotta è in linea con il contegno tenuto in sede di primo interrogatorio, quando egli non solo ha sottaciuto ma ha apertamente mentito in ordine a diverse, anche gravi, circostanze poi emerse a seguito delle accurate indagini svolte». Pur essendo Turetta a conoscenza del fatto che, oltre agli elementi fino ad allora emersi, vi era molto altro a suo carico, «si è guardato bene dal riferirne in sede di interrogatorio», essendo, di fatto, il suo «apporto stato del tutto nullo».
Neanche possono valorizzarsi «le circostanze dell’arresto dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non può certo ritenersi che Filippo Turetta si sia spontaneamente consegnato alle autorità: è stato invece necessario emettere un Mandato di Arresto Europeo ed è stato necessario attendere che egli esaurisse tutte le risorse che fino a quel momento gli avevano consentito la fuga, essendo oggettivo che fosse rimasto senza benzina, senza denaro contante e senza riserve alimentari (se non un pacco di biscotti)».
A fronte di tali plurimi e pregnanti motivi – si conclude – «la condotta processuale di aver acconsentito all’acquisizione degli atti di indagine non può che assumere valenza subvalente rispetto al disvalore rappresentato dagli elementi sopra esposti».